Il cambiamento in psicoterapia è al centro di frequenti dibattiti e riflessioni, da sempre e sempre di più, la psicoterapia prova a monitorare e documentare il cambiamento terapeutico. In questo processo, ogni volta, ci accorgiamo di come le variabili prese in esame, messe sotto la lente, siano sfuggenti o incomplete, parziali. Individuare il punto e il modo in cui avviene il cambiamento in terapia non è solo un esercizio per addetti ai lavori, ma un’inclinazione dello sguardo per chiunque si voglia occupare di salute mentale.
La relazione terapeutica è il luogo in cui questa possibilità di cambiamento può emergere. Non come promessa di rassicurazione costante, ma come esperienza ripetuta di sicurezza sufficiente: sufficiente per sentire, dire, sbagliare, fermarsi, tornare indietro, rimettere mano a ciò che prima era impraticabile. Succede quando, anche solo per un momento, prende forma un pensiero ancora incerto: qui forse posso restare anche mentre dico questo, senza difendermi. Posso dire questo senza sentirmi minacciato.
La comunità scientifica oggi concorda nel riconoscere che la qualità della relazione terapeutica è uno dei predittori più affidabili dell’esito della psicoterapia, trasversalmente agli orientamenti. Ma questo dato diventa clinicamente utile solo se ci interroghiamo su come la relazione funzioni, cosa sostenga e quando rischi di incrinarsi.
La relazione come struttura condivisa
Uno dei modelli più solidi per pensare la relazione in modo clinicamente rigoroso è quello proposto da Edward Bordin, che descrive l’alleanza terapeutica come composta da tre elementi interdipendenti: obiettivi, compiti e legame.
Questa formulazione riporta la relazione a una dimensione osservabile. Non riguarda solo come ci sentiamo, ma come lavoriamo insieme: su cosa, in che modo, con quale grado di fiducia reciproca.
Quando una terapia si blocca, spesso uno di questi elementi è fragile. Gli obiettivi non sono davvero condivisi, i compiti vengono vissuti come eccessivi o poco sensati, oppure il legame non regge quando emergono emozioni difficili. In questi casi, insistere sulle tecniche raramente aiuta. Serve tornare alla relazione come spazio di negoziazione, chiarificazione e sicurezza.
Questo vale anche fuori dal setting terapeutico. Quando il “fare bene” prende il posto del capire insieme, anche la relazione rischia di diventare prestazionale.
Essere accolti prima di essere compresi
Molto prima che si parlasse di alleanza in termini tecnici, Carl Rogers aveva posto una questione significativa: in quali condizioni una persona può smettere di difendersi da se stessa?
Empatia, autenticità e accettazione positiva incondizionata non sono atteggiamenti generici, ma condizioni relazionali che riducono la minaccia interna. Clinicamente, questo è evidente: molte persone non faticano a comprendere cosa accade loro, ma a stare in contatto con ciò che provano senza giudicarsi o ritirarsi.
La relazione terapeutica rende possibile questa prossimità. Permette di avvicinarsi a contenuti evitati non per mancanza di consapevolezza, ma per il costo emotivo che comportavano.
Psicologia cognitiva e relazione: collaborazione, non applicazione
Anche nella tradizione cognitiva, la relazione è sempre stata più centrale di quanto talvolta venga raccontato. Aaron T. Beck parla di empirismo collaborativo: terapeuta e persona come alleati nell’esplorazione dell’esperienza.
Negli sviluppi più recenti, questo aspetto è stato ulteriormente chiarito. Autrici come Christine Padesky mostrano come la collaborazione non sia solo un atteggiamento, ma un processo relazionale continuo, che attraversa obiettivi, compiti, verifiche e ripensamenti.
Clinicamente, questo ha implicazioni molto concrete. Un compito assegnato senza una reale alleanza può rinforzare il senso di fallimento. Un’esposizione proposta senza sufficiente sicurezza può risultare sopraffacente.
La relazione non è un prerequisito silenzioso della tecnica: è il canale attraverso cui passano motivazione, significato e apprendimento.
È anche uno dei punti in cui il lavoro terapeutico incontra il tema della prestazione: quando il cambiamento viene vissuto come qualcosa da “fare bene”, la relazione serve a sottrarre il lavoro su di sé a una logica valutativa che alimenta colpa e autocritica.
Attaccamento: la relazione come base sicura
Per John Bowlby, la sicurezza relazionale non elimina il dolore, ma rende possibile esplorarlo senza perdersi. La funzione della base sicura non è proteggere dall’esperienza, ma renderla attraversabile.
In terapia, questo si traduce nella possibilità di offrire una relazione in cui:
- le emozioni possono essere sentite senza essere agite
- il conflitto non coincide con la perdita del legame
- la dipendenza può essere riconosciuta senza essere né incoraggiata né svalutata
Jeremy Holmes ha mostrato come la relazione terapeutica possa diventare un’esperienza di attaccamento trasformativa non attraverso la regressione, ma attraverso la possibilità di pensare insieme gli stati mentali.
Negli sviluppi più recenti, Peter Fonagy ha introdotto il concetto di fiducia epistemica: la capacità di apprendere dall’altro senza sentirsi invasi, manipolati o umiliati.
Molte persone arrivano in terapia non solo ferite, ma profondamente sfiduciate. La relazione terapeutica serve anche a riaprire questa possibilità: tornare a considerare una relazione come una fonte affidabile di conoscenza su di sé.
La relazione come incontro reale
Irvin D. Yalom ha insistito su un punto semplice e essenziale: la relazione terapeutica è un incontro reale tra due persone reali.
Quando afferma che è la relazione a fare la differenza, non parla di spontaneità senza confini né di fusione emotiva, ma di presenza autentica e responsabile. Il terapeuta non è neutro, ma nemmeno centrale: usa se stesso come strumento, con misura e consapevolezza, al servizio del processo dell’altro.
Clinicamente, questo implica una domanda costante: sto usando la relazione per facilitare l’esplorazione, o per proteggermi dalla difficoltà che emerge?
Rotture, vergogna e possibilità di riparazione
Una relazione terapeutica viva non è priva di tensioni. Spesso è proprio quando ci si avvicina a qualcosa di significativo che emergono rotture: silenzi, ritiro, irritazione, distanza.
Il lavoro di Jeremy Safran e J. Christopher Muran ha mostrato che queste rotture non sono incidenti da evitare, ma momenti clinici centrali. Se riconosciute e riparate, possono favorire una riorganizzazione dell’esperienza relazionale.
Riparare non significa spiegare meglio o giustificarsi, ma portare attenzione alla relazione stessa, riconoscendo l’impatto reciproco. Dire: “Forse qui non mi sono accorto di qualcosa di importante per te” non è un gesto di debolezza, ma un atto clinico.
È qui che la relazione incontra direttamente il tema della vergogna.
Vergogna e compassione: la relazione come regolazione emotiva
Molti blocchi terapeutici sono legati alla vergogna: un’emozione che isola, irrigidisce, rende difficile chiedere aiuto.
Il lavoro di Paul Gilbert mostra come la relazione terapeutica possa diventare un contesto di riduzione della minaccia, piuttosto che un luogo in cui l’autocritica viene rinforzata.
Secondo Gilbert, molte persone non faticano perché non sono motivate, ma perché non si sentono al sicuro nel fallire. La relazione compassionevole non elimina la responsabilità, ma riduce quella forma di autocritica che blocca l’esplorazione e alimenta il ritiro. Non è l’emozione della vergogna in sé a rendere vulnerabili, ma l’isolamento che si crea quando non trova uno spazio relazionale sufficientemente sicuro.
Clinicamente, questo significa costruire una relazione in cui:
- l’errore non equivale alla perdita di valore
- la sofferenza non viene trattata come una colpa
- il cambiamento non assume la forma di una prova da superare
Custodire la relazione
La relazione terapeutica non è un contenitore neutro, né un clima da mantenere stabile a ogni costo. È un processo vivo, che richiede attenzione, disponibilità a rivedere la rotta, capacità di fermarsi quando qualcosa non funziona.
In questo spazio, il cambiamento non nasce dall’essere guidati nel modo giusto, ma dall’avere tempo e sicurezza sufficienti per pensare insieme ciò che, da soli, era rimasto confuso o indicibile.
Riferimenti bibliografici:
- Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance.
- Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change.
- Beck, A. T. et al. (1979). Cognitive Therapy of Depression.
- Padesky, C. A. (2022). Collaboration and guided discovery in CBT.
- Bowlby, J. (1988). A Secure Base.
- Holmes, J. (2014). Attachment in Therapeutic Practice.
- Fonagy, P. et al. (2015). Affect regulation, mentalization, and the development of the self.
- Yalom, I. D. (2002). The Gift of Therapy.
- Safran, J. D., & Muran, J. C. (2000). Negotiating the Therapeutic Alliance.
- Gilbert, P. (2009). The Compassionate Mind.

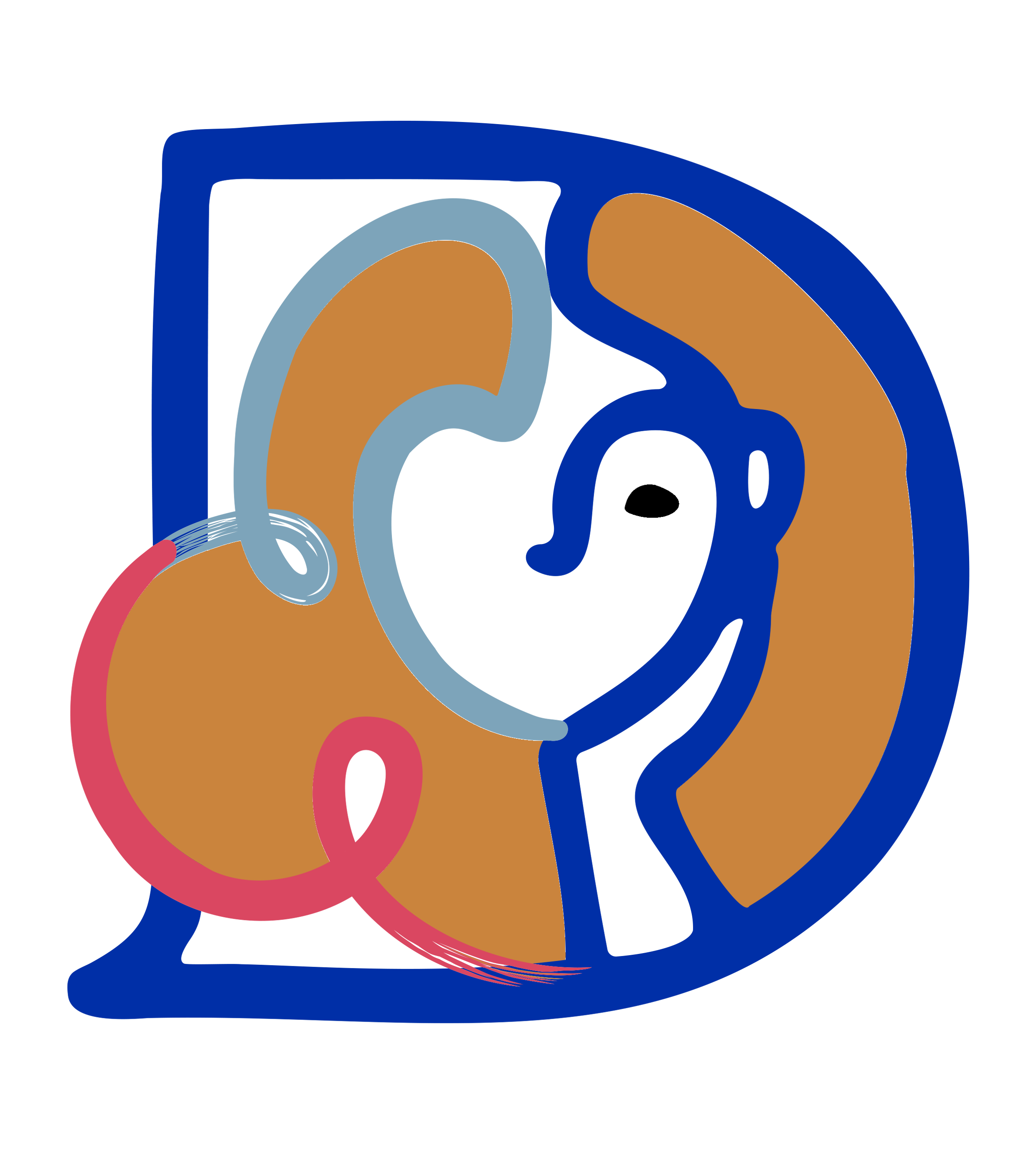


Lascia un commento